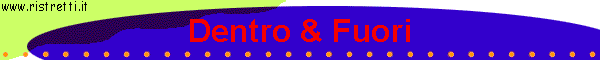
|
|
|
L’altra faccia dello sport è quella che ci ha mostrato Candido Cannavò, direttore "storico" della Gazzetta dello Sport e "frequentatore" del carcere per passione
Candido Cannavò lo conoscono tutti per i suoi vent’anni da direttore della "Gazzetta", ma ora lui ha messo la sua popolarità al servizio di una causa ben poco popolare tra la gente: quella del carcere e della sorte di chi ci sta dentro. Del libro "Libertà dietro le sbarre", che ha scritto per raccontare otto mesi passati a San Vittore da volontario, abbiamo già parlato sul nostro giornale, poi Cannavò è venuto a trovarci in redazione, e così abbiamo discusso a ruota libera di carcere, di sport, di doping.
Nicola Sansonna (Ristretti): La prima cosa che vorremmo chiederle è come le è venuta l’idea di scrivere un libro sul carcere, la seconda è capire qual è stato l’impatto del libro con i suoi lettori abituali, cioè coloro che la seguono attraverso i suoi articoli sportivi. Cannavò: Io non mi sono svegliato una mattina dicendomi: "Oggi voglio fare qualcosa sul carcere e su San Vittore". Seguivo San Vittore da circa tredici anni, da quando cioè è arrivato il direttore Pagano, perché con la Gazzetta dello Sport organizzavamo molte iniziative, gare, incontri con calciatori, per trascorrere qualche ora dentro. Da allora ho cominciato a capire che nel carcere c’è vita, una ristretta striscia di vita, dove esiste tutto: la speranza, l’umanità, i desideri, la fantasia; ci sono tutte le risorse che stanno anche fuori, e questo mi ha affascinato molto, per cui si sono fuse due cose: la mia curiosità giornalistica, che è istintiva per uno che fa questo mestiere da più di cinquant’anni, e quella che definirei una tensione morale, nel senso di dire "parliamo di questo argomento perché la gente non ne sa niente", e quindi se può se ne frega, per non dire poi della classe politica, per cui il carcere è solo un fastidio. Ogni tanto qualcuno ricorda ai politici il problema e questi spesso cercano di sorvolare perché, anche occupandosene, non si prendono voti in più. Perciò lo scopo del mio libro non e stato il libro del buonismo, del "facciamo vedere quanto è bello il carcere!". La realtà che ho raccontato non è così perché, per esempio, le celle del sesto braccio del secondo piano di San Vittore sono veramente il medioevo, per non parlare della sezione dei protetti dove c’è di tutto, perché in uno spazietto ridottissimo ci sono sei/sette persone, tre in piedi e tre a letto. Per cui nessuno può pensare "che bello, che umanità" e fermarsi là, non sarebbe giusto. Quanto all’impatto col mio pubblico, ci sono quelli che mi conoscono fin dalla nascita e sanno che io nella mia carriera ho fatto molte inchieste sociali, una in particolare sugli ospedali della Sicilia: addirittura un libro bianco, la prima denuncia della malasanità, si chiamava "I Lazzaretti di Sicilia", e poi sui manicomi, e ancora sugli aeroporti siciliani quando vi fu la tragedia di Punta Raisi. Quindi penso che un giornalista sia sempre un giornalista, poi è la vita che ti può portare a far prevalere l’interesse per lo sport, come è successo a me. Certo lo sport sembra non c’entrare con San Vittore, però oggi il mondo dello sport è più vicino al concetto della solidarietà, mentre prima non sapeva neppure che cosa fosse. Io sono, per esempio, patrocinatore di un progetto per istituire case per anziani in sedi di città di squadre della serie A, le 18 squadre hanno già fatto una compilation, in cui cantano tutti insieme, e i ricavati delle vendite vanno interamente a questo progetto. Quindi il libro, dopo questa sorpresa più che legittima perché da Cannavò non ci si aspettava l’argomento San Vittore, è stato accolto bene. Ora sto girando un po’ ovunque per presentarlo, anche se per me è una fatica, ma credo che si debba diffondere l’idea, la più banale del mondo, cioè quella che nel carcere ci sono delle persone. Si può dire "che grande scoperta!". è invece una grande scoperta, perché la gente per la maggior parte non sa che cosa c’è dentro, e se sapeste invece quanti ora mi mandano delle e-mail e mi vengono a chiedere come si fa a fare volontariato! Allora potete ben capire che grande soddisfazione sia per me. Quello che ho voluto comunque affermare, proprio a partire dal titolo, è, per chi sta dentro un carcere, la libertà di esserci, di appartenere ancora ad una società, di avere la parola.
Paolo Moresco (Ristretti): Considerati gli "umori" che ci sono oggi su temi come la sicurezza, i reati, la certezza della pena, mi interesserebbe sapere se ci sono stati anche dei pareri un po’ "estremi" sul suo libro da parte dei suoi lettori. Cannavò: Da tutti quelli che mi hanno scritto ho avuto soltanto complimenti, compreso, cosa che non mi sarei mai aspettato di ricevere, dal Presidente della Corte d’Appello di Milano, che ha detto che questo libro dovrebbe essere sul tavolo di tutti gli operatori di giustizia. Anche perché si legge facilmente (questo l’avete verificato anche voi), e però si vede che c’è una partecipazione emotiva che colpisce. Sinceramente non ho avuto nessuno che mi abbia accusato di aver scritto un libro inutile. è una testimonianza di otto mesi di percorso nel carcere, tra la gente, entrando in confidenza con le persone in un rapporto di stima e solidarietà reciproca, mantenendo però sempre le giuste distanze: se tu parli con uno che ha tre omicidi alle sue spalle, mentre gli parli, anche se ti affascina perché è un uomo diverso, non ti puoi scordare che stai davanti ad una persona con una storia pesante, l’unica ragione che uno come lui ha è che dopo trent’anni di carcere deve essere considerato un’altra persona, gli devono essere concesse delle chance, perché altrimenti, come diceva Marco Medda (ndr: un detenuto di cui Cannavò ha raccolto la testimonianza), altrimenti ammazzarlo sarebbe meglio, perché non può essere tenuto imprigionato all’infinito!
Paolo Moresco: Che impressione ha avuto del valore del tempo per chi lo deve trascorrere in carcere? Cannavò: Il tempo ha uno stravolgimento dentro il carcere. Fuori siamo delle persone che corrono, dentro, il tempo è qualcosa da ammazzare. Più ne ammazzi e più sei contento; però, parlando con la gente del carcere, ho scoperto anche un altro aspetto del tempo: cioè, chiedendo ad un detenuto la sua data di uscita dal carcere, poniamo che sia il 2012, lui parla di quello che farà in quel momento, progettando dettagliatamente il tempo come se il 2012 fosse la prossima settimana; e questo è un altro stravolgimento in senso contrario, qui dentro una data così lontana è vissuta come un filo di una speranza, un programma.
Paolo Moresco: Io sono qui "per forza", ma lei che ci è entrato per sua scelta conta di continuare a rimanerci o no? Cannavò: Il libro era finito già a fine ottobre, ma se io calcolo la frequenza, da ottobre ad oggi, con la quale sono andato a San Vittore, mi sembra proprio che tutto sia rimasto come prima, ormai è un processo irreversibile, anche perché con le risorse di questo libro abbiamo fatto un programma che si rivolge alle persone più vulnerabili che hanno a che fare col carcere: vedere per esempio in una cella una bambina di pochi giorni, nell’alba della sua vita, è una porcata, infatti al Comune di Milano, dove mi hanno convocato in una Commissione carcere, ho chiesto: "Quanti siamo qui, 13? Vergogniamoci tutti, perché se il Comune di Milano, avanguardia d’Europa, non riesce a risolvere il problema di sette bambini, non dico settanta, che cittadini siamo?". Io mi vergogno come cittadino, giornalista, essere umano, italiano di vedere sette bambini in carcere. Per la festa della donna hanno invitato delle stiliste, una cosa anche carina perché hanno detto che faranno dei corsi nel carcere per dare poi del lavoro alle cooperative, e c’era in prima fila una mamma nomade con due bambini, uno in braccio ed uno sulle ginocchia. Magari avrà avuto una condanna di tre mesi; ma che ci fa una mamma con una condanna di tre mesi in un carcere? Possibile che non si riesca a creare una piccola struttura alternativa? Facciamoli vivere in un appartamento o in qualsiasi altro alloggio più "normale" durante questi mesi in modo che questi bambini conoscano l’innocenza pura.
Nicola Sansonna: C’è stato un particolare, una storia, una persona che si può considerare la base, il punto di partenza del suo raccontare il carcere? Cannavò: Sono partito da alcune storie che mi avevano attratto, tra cui quella di Melodia, ragazza nera, colta, dolce e gentile, che viveva col suo fidanzato in Spagna, dove faceva un po’ la modella, un po’ la baby sitter, e studiava all’università. Quando sono entrati in Italia, hanno fermato il ragazzo con centoventi grammi di roba in tasca, lui ha patteggiato ed ha preso cinque anni, lei invece ha detto: "Da innocente non si patteggia" ed ha preso otto anni. Alcuni sono dei poveri disgraziati, queste colombiane che arrivano con gli ovuli di droga vengono con l’illusione di risolvere con un viaggio il problema della loro vita, guadagnando dieci, venti milioni, e invece qui trovano una radiografia ed il carcere, e la loro vita finisce con una condanna spesso lunghissima. Quindi sostanzialmente uno ha tenerezza per queste donne, cosa che non mi succede invece per Tanzi, perché, dopo che lo conosco da una vita, pensavo fosse una persona di grande spessore morale, un esempio per tutti, ed invece sono quindici anni che questo ci piglia per il culo! In questo caso mi fa più pena il povero extracomunitario che si inginocchia e che mi dice: "Ti giuro che mi hanno preso in mezzo ad altri, io non c’entro per niente!". E allora il dubbio ti resta, perché sono convinto che, quando c’è un processo, se ti chiami Cannavò e sanno che quello che ti succede andrà su tutti i giornali, magari stanno attenti; se trovi invece uno che si chiama Abdhullah... e non ha avvocati, non ha niente, otto anni chiedono ed otto anni sono. Questo non si può naturalmente generalizzare, ma il sospetto che accada è forte.
Marino Occhipinti (Ristretti): Non le sembra un po’ una contraddizione il fatto che nel nostro paese i presunti innocenti, cioè chi è in custodia cautelare (mediamente il 40% viene poi assolto) stiano nella maggioranza dei casi molto peggio delle persone già condannate? Cannavò: Io penso che la cosa più dolorosa, quello che mi ha lasciato più scioccato, il carcere che mi ha ferito di più è quello di chi arriva e non sa per quale reato sia là, delle persone che non sanno quando saranno giudicate, di quelli che non hanno un avvocato, quelli che sono a volte messi a dormire a terra perché non c’è posto, mentre dovrebbero essere assistiti più degli altri perché il primo impatto con la galera è quello che decide, e infatti statisticamente è dimostrato che gli episodi di autolesionismo sono frequenti proprio tra chi arriva in carcere e si smarrisce. C’è l’episodio clamoroso dell’ingegner Cagliari, era uno che poi hanno considerato un martire o un eroe, perché si è suicidato dopo due mesi di detenzione. Con tutto il rispetto per chi fa un gesto così estremo, lui che era un uomo ultrapotente ha scoperto San Vittore dopo che ci è finito dentro! è inutile denunciare i disagi quando si è dentro, bisogna cercare di farlo quando si è fuori! Una delle chiavi per creare veramente un rapporto con l’esterno è di fare delle visite dentro e riferire poi alla gente, perché è importante che la gente sappia che il carcere non è quella pattumiera che si immagina; è qualcosa che ci appartiene, una parte patologica ma non cronica, perché tutti qui siete di passaggio, la malattia può essere più o meno lunga, non è però una condanna che durerà per sempre.
Luigi Auletta (Ristretti): Che senso ha secondo lei parlare di sport in carcere? Cannavò: Io penso che lo sport sia un immenso sollievo, è una cosa di un’importanza estrema non solo da un punto di vista psicologico, ma anche per un fatto puramente fisico, perché la staticità della persona influisce sul corpo, sulla mente, su tutto. Comunque vi dovete anche convincere che purtroppo il problema dello sport nel nostro paese esiste non solo in carcere, ma per esempio anche per le scuole, è difficile trovare una scuola attrezzata come si deve per fare attività sportiva.
Ilir Ceka (Ristretti): Lei avrà visto che anche a San Vittore almeno la metà dei detenuti sono stranieri, come giornalista penso che possa essere interessante notare che nelle sezioni "d’avanguardia" come la Nave (N.d.R. sezione sperimentale per tossicodipendenti simile a una custodia attenuata) non ce n’è neanche uno, e in generale, un po’ per il fatto che si pensa che loro non abbiano possibilità di reinserirsi, agli immigrati vengono date meno opportunità, anzi sono spesso tagliati fuori dalle iniziative più innovative. Cannavò: Questa è una questione che io non ho preso in considerazione finora, adesso lei mi ha aperto gli occhi su questo, mi ha fatto un’osservazione che approfondirò. L’unica cosa che posso dire è che io a San Vittore non ho fatto distinzioni, ho parlato con tutti, anzi, devo dire che le storie più drammatiche ed emotivamente toccanti sono proprio degli stranieri, là dove la gente non ha punti di riferimento, parenti, notizie dalla famiglia.
Elton Kalica (Ristretti): Non lo so se la sua esperienza l’abbia portata a vedere anche il peggio del carcere. La mia domanda è: se non ha ancora visitato i luoghi dove si vive il disagio più profondo, ha intenzione di farlo in futuro e di scrivere anche su questo? Cannavò: Certamente in otto mesi ho avuto modo di visitare tutto, anche i luoghi peggiori, ma per quanto riguarda questi ultimi, devo riflettere ancora molto, anche su quello che ho sentito oggi da voi, non lo so se scriverò un altro libro allargando le esperienze, ma comunque io continuerò ad andarci, in carcere, e ho intenzione di continuare a scrivere sul Corriere della Sera, di non mollare; ormai è una cosa che ho assunto come un impegno della mia vita.
Ornella Favero (Ristretti): C’è un tema che nel nostro paese è abbastanza tabù e che riguarda la possibilità di avere colloqui intimi in carcere, cosa che in molti altri paesi, compresa la Spagna cattolicissima, è permessa. Noi su questa questione abbiamo elaborato, con degli esperti, una proposta di legge che è stata firmata da sessantaquattro parlamentari di tutti e due gli schieramenti, però è ferma lì: allora vorremmo sapere che cosa ne pensa lei di questa questione. Cannavò: Di recente sono andato a presentare il mio libro in Svizzera, a Lugano, lì hanno fatto vedere un documentario sul carcere "La Stampa" che raccontava la storia di una coppia di detenuti, che ogni mese si incontra in uno chalet, nell’area dell’istituto di pena, dove trascorre alcune ore in intimità: si fanno il caffè, la colazione, fanno l’amore. Io comunque sono favorevolissimo in assoluto a questo sistema, perché ormai sono fortemente condizionato, mi sono schierato, in questo momento il carcere è il mio pensiero principale e quindi senz’altro tutto ciò che ne può migliorare le condizioni di vita mi trova favorevole, nonostante quello che i benpensanti possono pensare.
Marino Occhipinti: Proprio ieri ho letto una sua intervista su "Vita" dove diceva che lei è schifato da questo calcio, e dal doping in particolare. Cannavò: Il doping è un cancro per lo sport. L’unica cosa che secondo me può ammazzare lo sport è la non credibilità, cioè se si pensa ad uno che ha fatto dieci secondi sui cento metri e l’indomani, dopo che sono stati scritti in tutto il mondo articoli sull’avvenimento, viene cacciato perché era carico di anabolizzanti, questa è la morte dello sport. La scorsa settimana mi sono trovato a Roma a parlare in un liceo con dei ragazzi che hanno fatto una ricerca interessantissima sul doping, lo scandalo è che anche in questa scuola che viene definita moderna, riformata, non ci sia un’ora alla settimana in cui si parla di droga e di doping. Fin dalle elementari si dovrebbero istruire i bambini, non è importante che ci siano controlli o repressioni, ma informazione. Adesso in Italia si sta facendo uno sforzo sul controllo del doping per chi fa sport, ma su dodici milioni di persone che fanno sport sia agonistico che amatoriale, si riescono a fare diecimila controlli al massimo, che cosa si risolve? A quei ragazzi ho detto: "L’unico rimedio siete voi, con la vostra convinzione di dover scacciare questo diavolo dalla vostra testa, perché vi rovina il fisico, ed anche la vostra stessa realtà, perché se uno ottiene un buon risultato sapendo che si è drogato, quale gioia può provare?".
"Credo che la scuola abbia molta responsabilità nella devianza"
Il Polo universitario come una sorta di risarcimento della scuola nei confronti dei detenuti: così lo vede Ione Toccafondi, direttrice del carcere di Prato
di Emanuela Zuccalà
Fa uno strano effetto sentirsi dire che un carcere riceve tantissime richieste di "ospitalità", come se fosse un posto speciale e ambìto. Eppure a Prato accade. Ad attrarre molti detenuti d’Italia è il Polo universitario, l’esperienza pilota che in questa casa circondariale alla periferia nord-ovest della cittadina toscana è partita nel 2000. Ma lo studio dietro le sbarre (sui 570 detenuti di Prato, i futuri dottori sono 54, tra Media e Alta Sicurezza) non è l’unico progetto innovativo in questa struttura: qui alcuni detenuti si dedicano all’addestramento dei cani per ciechi, e presto una sezione verrà riservata al recupero di chi ha commesso reati legati alla pedofilia. Delle attività del penitenziario di Prato, così in sinergia con il territorio, parliamo con Ione Toccafondi, direttrice dal 1996.
Università e carcere sembrano due mondi distanti anni luce. Al di là di qualche prospettiva lavorativa, che cosa può dare lo studio a una persona detenuta? Io credo che la scuola abbia molta responsabilità nella devianza: tante situazioni difficili potevano essere colte nell’ambito scolastico, e invece non sono state recepite e hanno portato a comportamenti devianti. Certo, la scuola non è l’unica responsabile, ma certamente ha fatto la sua parte. Quindi ritengo giusto che avvenga una sorta di risarcimento della scuola nei confronti dei detenuti. E poi, studiando, questi acquisiscono un’abilità sociale più facilmente spendibile all’esterno, oltre a un bagaglio culturale che li mette nelle condizioni di ripensare la propria vita in termini diversi. Lo studio li pone a contatto con una realtà spesso profondamente diversa da quella che hanno vissuto fino a un certo periodo della loro esistenza, e dà loro i mezzi per fare scelte diverse. Io dico sempre che gli operatori penitenziari, come strumento di lavoro, dovrebbero avere la sfera di cristallo: non siamo in grado di fare previsioni su quello che sarà, però ai detenuti dobbiamo offrire tutte le opportunità possibili. Starà a loro decidere se coglierle o meno. E la scuola è un’opportunità importante. Qualcuno, in carcere, ha seguito tutti i livelli scolastici: abbiamo un albanese, qui, che era quasi analfabeta. Adesso è iscritto a Scienze della formazione e vuole diventare educatore di comunità.
Com’è nata l’idea del Polo universitario? Fin dall’apertura, nel 1986, questo istituto ha avuto un’impronta legata allo studio. Quando sono arrivata io, abbiamo cominciato a portare qui la scuola pubblica, istituendo le classi di istituti professionali e tecnici in alta e media sicurezza, oltre alle elementari e alle medie. E c’era la voglia di proseguire, l’esigenza di formalizzare la cosa. Negli anni tantissimi ragazzi si sono diplomati in ragioneria, e abbiamo anche avuto detenuti che studiavano privatamente all’università, con difficoltà enormi per sostenere gli esami, soprattutto per chi non beneficiava di misure alternative o permessi premio. Ogni volta bisognava mandare la comunicazione all’università, che istituiva una commissione apposita, e i professori non venivano certo volentieri qui. Finché, nel 2000, è stata sottoscritta una convenzione con l’Università di Firenze, la Regione Toscana e il ministero della Giustizia, ed è stata avviata questa esperienza.
Qual è la differenza con il Polo universitario carcerario delle Vallette, a Torino, che fu la prima esperienza del genere, già nel 1998? A Torino i detenuti possono iscriversi solo a due facoltà, Giurisprudenza e Scienze politiche. Qui invece abbiamo l’intero panorama delle facoltà dell’ateneo fiorentino: il detenuto chiede di seguire un determinato corso di laurea, e si valuta se è in grado di farlo. Abbiamo studenti di ingegneria, informatica, storia del costume e della moda, architettura, giornalismo… E poi so che lì ci sono una serie di limitazioni: chi studia non può lavorare né accedere ad altre attività.
Qui invece gli studenti non rinunciano a nulla? Noi non poniamo limiti: se sono in grado di conciliare varie cose possono anche lavorare e partecipare ad altre attività. Anche la condizione che poniamo loro, di superare un certo numero di esami l’anno, non è rigida, perché dipende dalla facoltà: un esame di Lettere non è uguale a uno di Ingegneria. C’è una commissione che si riunisce spesso, e se i detenuti presentano difficoltà oggettive allo studio, le si valuta caso per caso. L’unico requisito – chiamiamolo così – che chiediamo loro, è la capacità di convivere in una situazione diversa dal resto dell’istituto: un’apertura quasi totale – le celle chiudono alle 18.30 –, la condivisione costante degli spazi, le attività sempre in comune. Insomma, devono essere capaci di autoregolamentarsi. Abbiamo registrato un paio di episodi negativi, ma nel complesso l’esperienza è sicuramente positiva.
È vero che avevate uno spazio libero da destinare al Polo universitario, e che questo è stato determinante per far partire l’esperienza? Sì, c’era una sezione vuota nella media sicurezza e l’abbiamo adibita esclusivamente agli studenti universitari. Le celle sono singole, di modo da poter studiare in tutta tranquillità, e dotate di scrivania, libreria, computer… Si è cercato di renderle più confortevoli. Lo studente di Storia della moda ha un manichino in cella, e quello di Architettura usa il tecnigrafo. Però anche noi a Prato abbiamo il problema del sovraffollamento: non è drammatico, perché nelle altre sezioni si sta in due o tre per cella, ma c’è. In Alta Sicurezza, per esempio, non è stato possibile creare una sezione solo universitaria: abbiamo dovuto mettere insieme gli universitari con altri detenuti, però studenti pure loro anche se di gradi inferiori.
Avete avuto difficoltà a realizzare questo ateneo dietro le sbarre? Come qualsiasi novità, all’inizio ha creato dei problemi: immagini quanta gente entra qui solo per occuparsi del Polo universitario. I detenuti non sono seguiti solo dai docenti, ma anche dai tutor, dalle associazioni di volontariato penitenziario di Prato, e poi c’è un continuo via vai di libri e materiale vario. Quanto al personale di polizia, devo dire che negli anni si è abituato alle attività trattamentali, e adesso capita che siano loro stessi a stimolarmi.
Secondo lei, si tratta di un’esperienza esportabile ovunque, in altre carceri, o ci vogliono condizioni particolari? È una cosa che non si può improvvisare, va fatta per bene per garantire a chi è interessato l’opportunità di studiare seriamente. In situazioni di grave sovraffollamento sarebbe impossibile: è necessario destinare un reparto agli studenti-detenuti, o anche solo un gruppo di celle, purché non si trovino a convivere studenti e non studenti, perché in questo caso non ci sarebbero le condizioni per portare avanti un impegno serio e costante.
Avete fatto da apripista ad altri penitenziari. Da Padova sono venuti il direttore e alcuni operatori per vedere come ci siamo organizzati e come funziona la nostra esperienza. Anche da Catanzaro ci hanno contattati per avere informazioni sul progetto.
Sarete subissati di richieste da tutta Italia. Soprattutto dal Sud. Purtroppo nell’ottava sezione, in Media Sicurezza, i posti per gli studenti sono solo ventitré. Così abbiamo deciso di dare la precedenza a chi si è diplomato qui e ai detenuti della Toscana. L’anno scorso si sono diplomati in sei: era giusto che completassero qui il loro percorso di studi. A mano a mano che si libererà qualche posto, con i detenuti che accederanno alle misure alternative, ne faremo entrare altri. Avevamo proposto al provveditore di riservare al Polo universitario anche un’altra sezione, ma questo vorrebbe dire trasferire un certo numero di detenuti, è complicato.
I detenuti del Polo sono studenti dell’Università di Firenze a tutti gli effetti. Che rapporti hanno con gli altri studenti, quelli liberi? Cerchiamo sempre di coinvolgere anche loro, oltre ai docenti. L’anno accademico è stato inaugurato qui, c’erano anche il rettore e alcune associazioni studentesche. Mio figlio per esempio, che ormai è già laureato in Ingegneria, è il fondatore della sezione fiorentina di Ingegneri senza frontiere, e ha portato in carcere molti suoi amici che continuano a venire. Insieme a loro i detenuti-studenti hanno visitato gli Uffizi, in gennaio, e insieme gareggiano in un torneo di calcio. Adesso ci sarà la partita di ritorno: l’andata l’hanno clamorosamente persa gli studenti liberi. E comunque, parlando con gli amici di mio figlio, ho notato che questi ragazzi considerano i detenuti come colleghi: non fanno differenza. È solo la burocrazia del carcere, i documenti e i cellulari da lasciare all’ingresso, che all’inizio li ha un po’ intimiditi. E i detenuti, a loro volta, hanno fondato un’associazione studentesca che si chiama Studeo: hanno intitolato il torneo di calcio alla memoria di un loro compagno che è morto l’anno scorso, durante un permesso, per un ictus. Era giovane, una cosa che ha sconvolto tutti.
Avete anche contatti con le altre scuole del territorio? Lavoriamo molto con le scuole: ogni anno le scolaresche entrano in carcere, quelle degli istituti superiori da cui provengono i docenti che insegnano qui. E poi c’è una scuola elementare: tutti gli anni le quinte vengono a incontrare i detenuti, ed è così bello vedere i bambini correre per i corridoi del carcere! Allestiscono uno spettacolino, poi scrivono dei temi con le loro riflessioni e ce li mandano da leggere. Dai loro scritti emerge che i bambini immaginano il carcere come un luogo molto brutto, ma quando vengono qui e parlano con noi scoprono che siamo persone normali, che nessuno qui indossa vestiti a strisce. Ce li ho tutti conservati, i loro temi: l’incontro con i bambini è sempre un’esperienza notevole.
Quali altre attività offrite alle persone detenute? Tante. Abbiamo un’azienda agricola interna e una serie di laboratori, oltre alla ludoteca per i figli dei detenuti che vengono a colloquio, gestita da Telefono Azzurro. Due volte l’anno cerchiamo di organizzare una festa della famiglia, l’ultima è stata a marzo: in una sala grande facciamo incontrare i detenuti con mogli e figli. Stanno insieme, i bambini fanno merenda, condividono con i padri parecchie ore della giornata. E poi stiamo sperimentando un progetto particolare, di affidamento di cani della scuola per ciechi di Scandicci. I cani possono essere addestrati per guidare i ciechi solo quando hanno un anno di vita, ma in questo anno devono comunque imparare a socializzare. La scuola affida quindi un cucciolo di almeno 45 giorni a un detenuto, il quale ovviamente abbia la possibilità di uscire, o in articolo 21 o in misura alternativa, perché deve abituare il cucciolo a prendere l’autobus, il treno, a salire sulle scale mobili… È una specie di pet-therapy, ma anche una forma di riparazione, perché il detenuto si adopera in qualche modo per un’altra categoria di svantaggiati: i ciechi che riceveranno il cucciolo.
E poi c’è un progetto per chi ha commesso reati di pedofilia. È un esperimento: un progetto di recupero per pedofili, con una serie di attività e di interventi mirati alla cura di queste persone, riunite in una sezione particolare. Coinvolgeremo detenuti che sono già qui, nella sezione protetta, e che ovviamente hanno grossi problemi di convivenza con gli altri: con il ministero cercheremo di trasferire gli "altri", per destinare l’intera sezione ai pedofili. Ci sono 46 posti: chiederemo alle sezioni protette della Toscana, e poi di altre regioni, di segnalarci chi vorrà essere inserito in questo progetto. Il lavoro sarà fatto con chi si renderà disponibile, non è certo una cosa che imponiamo. È un esperimento, ripeto, nessuno di noi ha la ricetta giusta. Speriamo che funzioni.
|