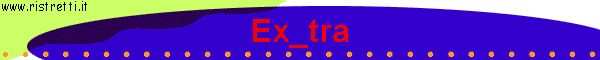
|
|
|
Ex_tra Periodico di informazione e cultura della C.C. "Dozza" di Bologna Numero 1, anno 1
Meditazione è la via della "consapevolezza"
Gianfranco Palma
Quando sentii parlare per la prima volta della meditazione Vipassana non sapevo esattamente di cosa si trattasse. Leggendo l’introduzione alla Pratica del Dharma, scritto da Carlo Pensa, ho iniziato a capire che l’argomento era molto vasto e di difficile comprensione: la meditazione è la via della "consapevolezza di sé", cioè del rimanere liberi ed indipendenti; la libertà è l’unico scopo della meditazione. Ha a che fare con la semplicità interiore, la "libertà dal condizionamento". Dovremmo chiederci se siamo realmente liberi interiormente o se siamo schiavi di qualcosa o qualcuno; fin quando rimarremo legati alla coscienza di noi stessi, come esseri che hanno bisogno di possedere cose, persone, supporto, piacere, approvazione, la pura coscienza rimarrà limitata e ristretta. La vera meditazione deve essere praticata, vissuta e portata nella vita, altrimenti non sarà veramente compresa. Bisogna stabilire un tempo da dedicare da un minimo di venti minuti a un massimo di un’ora e farlo diventare uno spazio fisso nella giornata. Si può stare seduti sul cuscino, sulla sedia, sulla poltrona, sul divano; in ogni caso la schiena deve essere diritta, senza assumere portamenti rigidi, questo permetterà di mantenere lo stato di veglia a lungo. La testa ben diritta, in linea con la schiena, con il mento leggermente rientrato e le mani raccolte in grembo: dobbiamo sentire la consapevolezza del corpo seduto con la dignità dell’essere umano, non dell’io-mio. E così, aperti all’attenzione del corpo, rivolgiamo l’attenzione al processo della respirazione, sentendola col naso, con l’addome, o seguendola laddove essa ci sembra più presente. Qualcuno proverà molte sensazioni, altri ne proveranno poche, va ber,e in entrambi i casi, l’importante è imparare ad utilizzare queste sensazioni come appigli per allenare la consapevolezza. Attivare la consapevolezza significa sentire respiro dopo respiro queste variazioni. Anche i rumori che ci circondano e che non possiamo eliminare si possono sfruttare per meditare. Si mediterà in mezzo a tanti rumori consapevoli di tutto, e la nostra consapevolezza crescerà. A volte l’esperienza del respiro, in dipendenza dalle condizioni, può essere piacevole, altre volte poco piacevole, entrambe sono ottime situazioni per la pratica e in entrambi i casi impareremo a rapportarci con equanimità, cosa che accadrà raramente se la sensazione è spiacevole e si prova avversione. Ecco perché occorre una pratica che richiede tempo. La "consegna della pratica" è di unirsi consapevolmente con il respiro, con "questo respiro"; la respirazione mancata è storia passata, le respirazioni che prenderemo non esistono, la respirazione attuale è l’unica sperimentabile. Questo non significa restare nel presente ma è riportare nella meditazione quella mentalità che ci procura molta sofferenza, perché è una mentalità che vuole controllare l’esistenza nostra e degli altri. Si chiama tormento, oppressione, e nella lingua pali si dice "dukka", cioè sofferenza. Noi non siamo certo abituati a questo tipo di attività, non viviamo in una cultura che ci sostiene sotto questo aspetto. Nelle carceri italiane poi gli interessi e gli stili di vita di ogni singolo detenuto sono diversi tra loro, ma quasi sempre molto distanti dai principi della meditazione. Quindi ci troviamo fortemente contro corrente. Di fronte alle sensazioni la consapevolezza funziona come uno specchio: c’è la sensazione procurata dall’evento e c’è la consapevolezza dell’accadere dell’evento. La consapevolezza ci fa vedere e ci riflette la natura delle cose così come sono, senza sovrapporre giudizi. Ci aiuti a guardare le sensazioni senza esprimere giudizi: questo è fondamentale, in quanto guardare e toccare le sensazioni con la consapevolezza è come guardare e toccare la "sofferenza". Riuscire a cogliere l’attimo in cui una sensazione di rabbia sorge dentro di noi è la consapevolezza del sorgere della rabbia. Oppure imparare a muovere la nostra consapevolezza verso il "disagio", quindi riconoscere le ansie, le angosce, ma anche i disagi fisici. Si osservano queste sensazioni spiacevoli senza intervenire per modificarle né sopprimerle, al contrario vanno osservate per tutto il tempo che durano. E’ questa la migliore strada per arrivare all’osservazione degli agi, della felicità e della gioia e per apprezzarli molto di più. Altro punto fondamentale è la "presa di rifugio nei tre gioielli". Per "presa di rifugio" s’intende scegliere…, decidere per…, qualcosa che in qualche modo ha la capacità di proteggere e di custodire. La presa di rifugio è un fattore essenziale nel cammino proposto dal buddismo, e soltanto se è fatto con una motivazione chiara e autentica può far raggiungere la liberazione dalla sofferenza. Il primo dei tre gioielli: il Buddha, il rifugio nel Buddha è un ritorno in quella parte di noi che è già risvegliata, e offre un’opportunità di pace, di serenità, una sospensione almeno temporanea dei principali fattori inquinanti della mentre, cioè l’ignoranza, l’attaccamento e l’avversione. Il secondo gioiello: il dharma, può assumere diversi significati: quando è scritto con l’iniziale minuscola, può indicare i fenomeni del mondo relativo, soggetti alla nascita e alla morte, privi di un’esistenza intrinseca. Quando è scritto con la maiuscola, può indicare sia l’insegnamento del Buddha, sia la lealtà ultima,l’incondizionato. E a questi due significati si riferisce la presa di rifugio nel dharma: rifugio in un insegnamento che conduce alla liberazione e rifugio nella liberazione stessa. Dharma infatti è la pratica nella qual è possibile cominciare a sentire un sostegno. Infatti il significato etimologico della parola dharma è "sostegno". Il terzo gioiello è il Sangha: per Sangha s’intende l’insieme di coloro che dirigono le proprie energie verso il risveglio, verso la fine del dolore. Sono le altre persone, i compagni che condividono questo cammino, sono per noi e noi per loro, un sostegno. In conclusione, rifugiarsi nei tre gioielli, richiede una profonda comprensione della propria motivazione a percorrere un sentiero spirituale, insieme alla capacità di intrigarli nel proprio modo di vivere. In base a questi criteri, anche se con qualche diversità, furono proposti corsi di meditazione in cui si riunivano più di mille persone, della durata di dieci giorni, questo avveniva nel 1993 nel carcere indiano di Tihar a Nuova Delhi, riscontrando un enorme successo. All’inizio mi sembrò una leggenda, quando lessi il libro "La coscienza di se", incominciai a capire il magnifico operato di Kiram Bedi, prima direttrice donna del carcere di Tihar ed ex ufficiale di polizia, la quale propose moderne iniziative oltre la meditazione, che cambiarono radicalmente in meglio la detenzione carceraria, in uno Stato in cui non esistevano leggi a riguardo, solo basandosi sulle proprie possibilità ed esponendosi in prima persona. Un lavoro notevole, se pensiamo che la legge Italiana già prevede pene alternative al carcere, e già prevede che la condanna da espiare, sia utilizzata al fine di preparare ed istruire il detenuto ad un reinserimento graduale nella società; purtroppo, però, sono applicate raramente e solo in alcuni istituti penitenziari. Le iniziative proposte da Kiram Bedi, in un carcere in quelle condizioni di degrado, scarsa igiene, mancanza di personale medico, mancanza di sicurezza, ma abbondante di corruzione, potrebbero risultare innovative nei nostri istituti, anche a distanza di un decennio. Voglio portare come esempio l’esperimento della conversione dei rifiuti in concime. Un carcere di 8700 detenuti produce ogni giorno 3000 chilogrammi di spazzatura, un compito abbastanza gravoso da trattare. In collaborazione con la EXEL INDUSTRIES di Bombay, furono istituiti dei corsi per imparare a trattare i rifiuti; aderirono 40 detenuti, ricevendo oltre a incentivi finanziari, anche sconti di pena. E la vendita di concime ha avuto forti consensi e nacquero altre idee, come ottenere elettricità dai rifiuti o estrarre bio-gas dai rifiuti prima di convertirli in letame. A dimostrazione della validità e dell’innovativa iniziativa, nel periodo ‘99-2000, fu proposto un corso analogo con successiva apertura al lavoro interno, a Rebibbia, in collaborazione con Lega Ambiente. Riscontrò un discreto successo, anche dai detenuti più restii al lavoro, e ne sentii parlare con entusiasmo da parte dei partecipanti. Ora, è lampante che nelle nostre Patrie galere la meditazione silenziosa proposta come a Tihar sarebbe un grande flop… L’Italia non e L’india, Bologna non è Nuova Delhi, sono due mondi a se, due culture diverse, però potremmo fare altro.... Kiram Bedi ci insegna soprattutto com’è possibile far confluire un migliaio di persone verso un unico obbiettivo, ed è ciò che nelle nostre strutture manca. Idee collettive che stimolino l’entusiasmo dei detenuti e che permettano a chi vuole di cambiare, di migliorarsi e di crearsi una nuova vita. Intanto, il 27 Marzo ho ottenuto il mio permesso premio, dalle ore 14,00 alle 20,00, accompagnato dalle volontarie del gruppo "Una Via", promosso da Pier Cesare Bori, professore di filosofia morale; e da Marco Bonfiglioli, coordinatore della Casa Circondariale di Bologna. Lo scopo di questo permesso è stato quello di partecipare alla proiezione del film "Doing Time, Doing Vipassana", e con l’occasione per presentare il numero ZERO della nostra rivista EX-TRA. Il documentario realizzato da due registe Israeliane, Ayelet e Eilona Ariel, premiato dal Festival Internazionale di San Francisco nel 1998, descrive gli sforzi e la perseveranza di Kiram Bedi nel realizzare il progetto che è oggetto di studi in tutto il mondo. L’intento è quello di riabilitare i detenuti e di diminuire la recidività, con l’introduzione, appunto, di nuove regole, nuove iniziative e soprattutto della meditazione Vipassana, al fine di acquisire la "consapevolezza di sé", degli errori commessi e dei disagi subiti, come ho descritto prima. Il filmato-documentario, ha dato un’idea più precisa e chiara, ed ha evidenziato sostanziali differenze con la realtà delle carceri Italiane; l’immagine di un agente che abbraccia un detenuto in lacrime di gioia all’uscita del periodo di 10 giorni di meditazione silenziosa, è rappresentativa…!!! Dopo il filmato eseguito un dibattito attorno alla funzione riabilitativa della pena in cui sono intervenuti il prof. Pier Cesare Bori, protutore dell’evento; il prof. Centone dell’Università Cattolica di Milano, collaboratore del prof. Stella, docente di diritto penale presso l’Università Cattolica di Milano, i quali hanno già ospitato la signora Bedi in un seminario tenuto a Milano. E ancora, Pier Luigi Gonfalonieri, rappresentante dell’associazione Vipassana Italia, e per finire, la mia "compagna di permesso": Patrizia, detenuta presso il reparto femminile della Casa Circondariale "Dozza" di Bologna e per l’occasione, rappresentante della redazione di questa rivista. Il dibattito, in cui sono intervenuti anche "addetti ai lavori" presenti in sala, si è basato sull’inserimento di corsi sulla meditazione Vipassana nelle carceri italiane, sulle problematiche legate al lavoro interno e al sovraffollamento, e sulle possibilità di reinserimento del detenuto, che la legge prevede ma non sempre viene applicato. Erano presenti in sala: la dott.ssa Cerasani, nuova direttrice in missione; la vice direttrice dott.ssa Mercurio; il dott. Reo, direttore dell’area pedagogica e responsabile degli educatori, e la dott.ssa Longo, Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Bologna. E sono rimasto piacevolmente stupito nel vedere l’affluenza di persone di tutte le età e ceti sociali accorsi alla manifestazione. L’evento si è concluso intorno alle 17,20, con successo, e molta della gente intervenuta ha chiesto informazioni sulla meditazione e sulla nostra rivista. Che soddisfazione! Comunque, fatti i saluti di rito,ci siamo intrattenuti per le vie del centro, per poi concludere la giornata col tragico rientro in carcere… Dopo due anni e mezzo chiuso in una cella, mi sono trovato catapultato in un cinema, con a occhio e croce, 200 persone intorno…, quante emozioni…! Non riuscivo a riorganizzare le idee, ero uscito con l’intento di fare qualche telefonata ai miei cari e di mangiarmi quei dolci che tanto reclamizzano in televisione e che noi non possiamo comprare! Per le telefonate è andata bene, ma lo stomaco era chiuso, chiusissimo, e sono tornato con due misere pastarelline sulla coscienza…, che figuraccia! Per concludere, spero che l’opportunità datami, in futuro venga data anche ad altri detenuti, e ringrazio tutti quelli che l’anno resa possibile.
Il carcere può essere la soluzione delle nostre paure?
Davide Pagenstecher e Pasquale Di Palma
Il carcere può essere la soluzione delle nostre paure? La vita nell’età neoliberista catalizzata dai media, che ci chiudono in casa e ci sottopongono ad inquietanti bombardamenti sull’allarme criminalità, rendendoci tutti più soli e diffidenti verso gli altri. Le piazze e le strade che si svuotano la sera trasformandosi nel loro grigiore in un simbolo tragico delle nostre paure. Il cittadino terrorizzato che invoca lo Stato per la richiesta della cura delle sue, e delle nostre angosce invece di provare a ricostruire più automaticamente le reti sociali. Lo Stato, appiattito sulla dimensione repressiva nel momento stesso in cui si esime dall’impegno nella promozione del benessere e dell’equità, agisce come sistema di controllo applicando diversi livelli di repressione sociale e il carcere diviene una fiorente quanto giustificata industria al suo servizio. Nell’ottica in cui è trattato l’argomento il grande nemico della società o comunità umana è lo Stato, nella sua interazione con i movimenti politici; se si discute di criminali pericolosi, non è il caso di parlare solo di individui, ma più generalmente dello Stato. Se a causa dell’infrazione di un articolo del codice penale si accede a una prigione, russa, americana, europea che sia, è alto il rischio di non uscirne vivi o di uscirne distrutti sul piano psichico e fisico e conseguentemente danneggiati irreparabilmente in relazione alla tessitura di nuovi rapporti sociali. Lo Stato è pertanto un elemento decisamente pericoloso per il genere umano, specie nel novero dell’applicazione del sistema penale, che pare non trovare alternative logiche in afferenza al sistema behavioristico umano (in senso universale) in condizioni di restrizione. Per questo è fondamentale l’impegno per difendere la società civile: non è possibile assistere in modo apatico a un trend come quello occidentale, che nel corso degli anni ‘90 ha visto quasi raddoppiare il numero dei reclusi: alcuni milioni nelle nazioni occidentali (oltre 700 ogni 100.000 abitanti), molti dei quali poveri o scomodi per il potere in funzione di come esso viene concepito, quindi stereotipato e assunto come riferimento normativo dalla maggior parte degli strati della società. Questo significa che ormai si impegna il sistema penale per dirigere la società, invece di promuoverne lo sviluppo con il welfare state e la formazione civica che ne dovrebbe derivare. Il sistema penale non trova davanti a se controparti dotate di quadri di riferimento che consentano un confronto teorico fondato anche solo su analisi empiriche: pertanto è difficilissimo ostacolarne la continua espansione in società come la nostra. In che modo si può tentare di avviare un percorso etico canalizzato verso un sistema alternativo di risoluzione dei conflitti e di approccio al crimine? Nel chiederti chi detenga la "proprietà dei conflitti", pare tutt’altro che naturale che sia lo Stato: ma dove porre, allora, e quale valore dare al processo di formulazione razionale delle scelte individuali o collettive che astraggono dalla predominante logica ingerenziale dell’agire statuale che si pone come elemento coattivo? Da questo punto di vista, i giuristi possono essere considerati come ladri professionisti, poiché rubano i conflitti altrui ponendosi come onere la prerogativa di risolverli, anche quando ciò diviene arroganza. Un totale abolizionismo in merito al sistema penale è impensabile, laddove questo è un archetipo del pensiero collettivo; ma è perlomeno auspicabile che parte de!le sue prerogative siano trasferite a metodi alternativi che non sottovalutino le discipline che propongono un’attenuazione dell’applicazione del processo penale in afferenza alle sue conseguenze sia sul piano privato o individuale che pubblico. Non si tratta di trascurare la forma di difesa dei diritti individuali sviluppata nei secoli, ma di secolarizzarla e di migliorarla nella prospettiva di soluzioni più pratiche e costruttive. Il diritto romano prevede l’obbligatorietà dell’azione penale, quello anglosassone no, o almeno in minor misura considerando come fattore causale fondamentale la denuncia individuale o collettiva, e contemplando, nel corso del processo accusatorio, la suddivisione delle parti in causa come elemento deontologico ed etico-strategico essenziale per un equo giudizio. Nel diritto romano lo Stato si pone a priori come padre-padrone del dibattito e dell’analisi giurisprudenziale, defraudando un individuo del diritto di poter incidere oltre un certo limite (e dipende dai casi) nel processo decisionale e normativo che lo coinvolge in modo diretto. Ora, non si tratta di criticare negativamente un metodo piuttosto che l’altro, ma di tornare all’analisi dell’aspetto più o meno interventista per verificare se esso comporti necessariamente una soluzione ottimale delle controversie. Qual è la ragione reale che impedisce il canale alternativo, ad esempio anche in casi seri di violenza, quando entrambe le parti, vittime e imputati, sono d’accordo? È la volontà di tutelare il potere dalla società. E perché le professionalità che qui entrano in gioco, quali magistrati e avvocati che devono difendere i loro interessi, non possono accettare che la gente, in una società civile, riesca ad arrangiarsi nella risoluzione delle controversie senza di loro? È forse una questione prettamente referenziale, oppure la cultura della metodologia statuale di coazione non riesce, nel novero del sistema formativo legislativo, a trovare alternative all’ottica conservatrice? Così si continua a far danni sociali utilizzando il sistema penale. Se guardiamo invece ai conflitti che si generano fra le grandi società commerciali o industriali, ci rendiamo conto che si cerca sempre una soluzione per evitare il muro contro muro in tribunale, una prospettiva che sarebbe deleteria e foriera di nuovi conflitti. Il concetto parrebbe ovviamente elementare anche per i rapporti sociali e privati. Dunque, semplicemente non lo si vuole capire, ponendo di fatto delle differenze che vivono ai margini del diritto stesso e della legalità intesa come sistema di leggi che difficilmente, in barba ai principi normativi essenziali presenti nella maggior parte dei testi costituzionali, sono uguali per tutti. Quest’ulteriore, ma intrinseca epistemologia del sistema statuale è ovviamente endogena all’insieme coazionale di produzione in assenza di alternative o di volontà di ricerca e, pertanto, suscettibile di essere intesa come maculazione, discontinuità etico-morale sul piano dell’applicazione, che non tende nella maggior parte dei casi a fornire alcun tipo di giustificazione plausibile anche qualora pecchi di manifesta inefficienza e inadeguatezza. Per cominciare, lo Stato, ogni organizzazione statuale, vuole poter governare e giudicare gli individui e le professioni coinvolte in conflitti sociali, quindi più ce ne sono meglio è poi abbiamo la nostra tradizione culturale, così legata all’idea del castigo tanto nelle sue matrici storiche di ascendenza secolare che nell’ermeneutica escatologica tipica del corpus religioso al quale per secoli abbiamo fatto riferimento senza,pare,soluzione di continuità, cui si contrappone la corrente che sostiene il perdono intravedendo in essa una logica soteriologica e pertanto, a tratti, fuorviante. Tutto ciò è un meccanismo perverso che alimenta il regime della delega al sistema, che favorisce la sottrazione di responsabilità ai singoli componenti della società e la perdita di consapevolezza sui doveri e sui diritti del vivere in comunità. Un altro ambito organizzativo, in definitiva, che sembra fatto apposta per allontanare l’individuo e la sua proiezione identitaria dall’incontro con gli altri. Rianimare la vita sociale, gli intrecci e il dialogo tra le persone sembra infatti uno degli effetti collaterali significativi di un percorso alternativo per la soluzione delle controversie. L’idea di fondo di questi percorsi alternativi è il superamento del concetto di pena. Si può ipotizzare, in un’ottica astratta, che non esista il crimine, ma solo l’azione da punire O da capire. Quali sono le condizioni sociali che determinano la lettura di un’azione nell’una o nell’altra direzione? Se siamo favorevoli a una società civile fatta di individui responsabili, se abbiamo questa tendenza autoregolamentativa, allora dobbiamo impegnarci a organizzare la società in modo che le azioni siano viste come qualcosa di diverso da un "delitto". Le azioni non sono: diventano. Questo vuoi dire che non si potrà mai rispondere coerentemente ne razionalmente alla domanda: la criminalità è in aumento? Il crimine dipende da che cosa in una data società viene considerato tale in relazione ad un preciso sistema di valori che inquadra come tale un segmento di struttura culturale marginale e non egemonica. Quindi, al massimo si potrà dire che è stato registrato un aumento dei reati, ma non si potrà dire che la criminalità è in aumento. La criminalità è un’opinione (vedi sopra) determinata da un preciso sistema di valori etico-morale. Un fenomeno culturale può essere espresso nella comprensione di determinate azioni anche a prescindere dalle leggi di un dato tempo e luogo, e ciò vuoi dire individuare una volontà analitica rivolta al progresso. C’è forse qualcuno di noi che con i suoi atti non infrange la legge ogni tanto? No. Il codice penale non ci aiuta a capire la criminalità, si limita a classificarla per articoli. Siamo in una situazione in cui i politici hanno poco di cui discutere (se non sul piano internazionale): persi gli ancoraggi ideologici, dominano le leggi del mercato e dei soldi. Chi propone approcci alternativi, come in questo caso, non viene per nulla ascoltato. Dunque, non sono accolti attualmente nella politica i portavoce dei valori sociali antisistema, non c’è chi complica il dibattito, c’è chi invece rimane legato comodamente alla soluzione penale. Intanto la criminalità diventa un buon terreno per riscaldare gli animi e mietere facili consensi. Questo è evidente in molti paesi considerati a regime democratico a cominciare da quelli evoluti sia economicamente, sia politicamente nel contesto occidentale; se la tua immagine di uomo politico appare troppo debole sul fronte della criminalità, per te è finita; la maggioranza ti volta le spalle, "sei amico dei nemici del sistema". Considerando che un individuo mediamente dotato di intelletto dovrebbe rendersi conto di quanto sia facile finire tra chi infrange qualche legge, come mai è così semplice manipolare l’opinione pubblica con l’allarme criminalità? Perché la stessa persona media non riesce a identificarsi mai con una certa azione criminale. Ora, questa mancata capacità di relativizzare, di tentare di capire le relazioni e i conflitti, è legata al crescente isolamento sociale, all’angoscia crescente; quella delle strade vuote, quella del bombardamento mediatico a cui siamo costantemente sottoposti. La gente sta chiusa in casa perché ha paura di ciò che vede in televisione, ma anche perché fuori non c’è nessuno; fuori, nel buio, c’è solo la minaccia. Ecco, allora, che questa logica torna utile al sistema e a chi "ruba i conflitti" (vedi sopra). I mass media sovraespongono i fatti criminali, li rendono talmente centrali da spaventare e la gente spaventata alimenta il circolo vizioso fornito dagli insiemi distortamente stereotipati che consentono una maggiore tiratura e producono manifeste distorsioni etico-culturali. Ci vorrebbero nuovi spazi di riflessione, dibattiti veri e non le retoriche primitive che ci offrono oggi gli speculatori politici e mediatici. Assistendo a un dialogo piuttosto che a un processo, in relazione a un gesto considerato amorale, ci si renderebbe conto di come, con il dialogo e una sana dialettica, le persone cercano di farsi capire. La vittima può cominciare a rendersi conto un po’ alla volta che l’aggressore è una persona normale, questi comincia a capire ciò che ha combinato. Può finire con una stretta di mano e questo sembra l’epilogo moralmente più accettabile, di sicuro più che affidare la pratica a un funzionario del sistema penale. Coinvolgere la popolazione sulla questione del conflitto e della partecipazione può costituire un nuovo e più reale sistema di consapevolezza. In relazione alla reiterazione dei reati, non si riuscirebbe mai a capire chi sono i componenti di questo insieme. La scelta della detenzione si può immaginare solo quando fallisce del tutto la mediazione oppure in caso di azioni così violente e raccapriccianti da far ritenere che il cittadino non accetterebbe una condizione diversa per l’imputato. Torniamo agli aspetti culturali. Va tenuto conto che rinchiudere una persona in un carcere aumenta la probabilità della reiterazione del reato una volta scontata la pena. Quando mandiamo i nostri figli a scuola è perché pensiamo che lì imparino delle cose e abbiano una vita sociale; che cosa significa invece mandarli in prigione? Come saranno quando usciranno? O vogliamo forse avere dei giganteschi campi di concentramento in cui si entra e non si esce più. C’è chi difende il carcere come strumento preventivo, la pena come deterrente, ma i risultati delle ricerche statistiche dimostrano come questa metodologia interpretativa sia fallimentare rispetto alla divulgazione di una cospicua e corretta cultura civica. È molto bassa la probabilità che una persona non compia un’azione perché un altro individuo è stato incarcerato per un atto analogo. Quando uno perde il controllo, difficilmente pensa al codice penale o a chi sta in cella. E nemmeno chi agisce per un bisogno economico o in base a meccanismi di gratificazione innescati da un ambiente degradato in cui la violenza è l’unico mezzo per emergere pensa alle conseguenze. Insomma, si tratta di una battaglia culturale su più fronti. Siamo tutti potenziali criminali, dipende dall’ambiente e dal modello culturale ad esso legato. Ma cos’è il carcere, e come agisce sulle persone? In carcere, la condizione detentiva identifica il soggetto con forza ben maggiore della sua personalità. Un sistema che in primo luogo agisce per deprimere se non per annullare la personalità del soggetto; una tendenza a trasformarlo in un nulla, in una presenza marginale definita secondo gli schemi di un generico quanto falso perbenismo. Questo scopo è generalmente realizzato sia con gli strumenti della coercizione psicologica che della violenza fisica e del ricatto, nonché con quelli preventivi della censura e dell’imposizione del silenzio. Non si può semplicemente riconoscere come perversa o aberrante la struttura carceraria in se. Essa risulta tuttavia tale alla luce dell’incongruenza delle coordinate giuridiche ed istituzionali che la definiscono come organizzazione e precisamente, da una parte, delle norme di riferimento come la Costituzione italiana e la carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo, e dall’altra del sistema amministrativo vigente con le negligenze e il dispotismo che gli sono proprie, sempre giustificati con motivi futili, arroganti e fondamentalmente deviati. Questo dovrebbe dipingere, a grandi linee, l’immagine di un sistema assolutamente totalitario e regressivo, che vive e vige in aperta contrapposizione con uno Stato di diritto che si ritiene democratico ma che non lascia spazio ad alcuna logica che non sia quella dell’alimentazione e della gratificazione di se stesso. Parecchie volte, negli anni, i detenuti hanno cercato di proporsi come soggetti dinamici, vivi, presentando progetti e idee innovative, interpretando istanze di cambiamento e di riflessione; altrettante volte tutto ciò è stato recepito come null’altro che una fonte d’irritazione per quelle figure istituzionali che in carcere sono letteralmente appellate come le "signorie Vostre".Da parte di queste ultime non si ammette di norma che il detenuto possa pensare ad altro che non sia la minuta obbedienza quotidiana, che possa voler rivendicare i propri diritti intromettendosi nel funzionamento perverso di quella totalità che da esso nulla tollera e poco gradisce. Gli organi istituzionali presentano il carcere non solo come luogo di pena, ma anche come ente statale atto al recupero e al reinserimento dei soggetti detenuti. Con ciò, in buona misura, viene affermato il falso. Cosi com’è oggi il carcere è luogo di educazione al crimine, di inasprimento della cattiveria individuale e generale, che sottende la reiterazione dei reati (vedi sopra) e più genericamente un modus vivendi che alimenta il circuito stesso. Se non per scelte personali o interventi di elevato spessore culturale provenienti dal volontariato esterno, è quasi impossibile assistere o prendere parte a iniziative volte seriamente alla formazione, alla reintegrazione e al reinserimento quali questi dovrebbero essere considerati, cioè un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e dall’Ordinamento Penitenziario e anche una garanzia per la società, la quale, nella sua aspettativa di riaccogliere individui mutati e migliori, può sentirsi per questo truffata e circuita. In questo modo non si aprono sbocchi professionali, ne hanno luogo processi di formazione etica individuali o collettivi, mentre proliferano le menzogne utili a mantenere vivo e funzionante un circuito-sistema penitenziario che, al collasso per un intrico di motivi che non manifesta l’intenzione di risolvere, si nasconde dietro la facciata del falso perbenismo. Non è forse questo sistema di coazione statuale, più criminale di molti individui che a volte lo subiscono anche ingiustamente? La soluzione penale, come si è dimostrato, sottende un insieme di manifeste dissonanze cognitive che non portano alla soluzione delle paure stereotipate nel popolo, ma danneggia sia la realtà già espressa, sia l’opportunità di ricercare soluzioni alternative in un clima di serenità ove si possa sviluppare una seria e costante analisi del fenomeno, tesa a un mutamento radicale della logica punitiva e penale.
(Quest’articolo è stato realizzato prendendo spunto, in parte, da un’intervista rilasciata dal noto criminologo norvegese Nils Christie, che da cinquant’anni studia il fenomeno della soluzione penale ed è considerato uno dei padri fondatori della teoria riduzionista dell’applicazione del sistema penale.)
"Non possiamo dirigere il vento… ma possiamo orientare le vele"
Gianfranco Del Mastro e Felix Jesus Alexander
Dall’inizio dell’anno suona per tutte le strade del Paese un triste "tam tam" di guerra, la criminalità dilaga, omicidi, furti, rapine; la gente non ne può più: tolleranza zero! Giornali e televisioni cavalcano il malessere ed ogni reato, da quello efferrato, al quale è dato giusto risalto, e quello banale conquista la prima pagina: la popolazione è insofferente e in ogni testata ambisce a diventare la sua voce. Alcune reti nazionali, dopo aver diffuso enorme allarme tramite i telegiornali, impiegano tutte le tecniche più raffinate della retorica, mandando in onda pellicole nei quale il protagonista, insultato, derubato e violentato, riesce a catturare il bruto consegnandolo alla giustizia che, complice e lassista, immediatamente lo rimette in libertà. Quello che fa? Subito torna dalla vittima costringendola a subire ogni tipo d’angherie psicologiche, inducendolo alla ribellione e, sordo al richiamo di tutte le autorità preposte, la spinge al punto di farsi giustizia da sola, uccidendo il reo e raccogliendo tutta la solidarietà della gente. Risultato a Milano, un tale uccide un ladro in fuga. Rimane un dubbio: la TV aveva preconizzato ciò che sarebbe successo o aveva suggerito il da farsi? Accanto al giusto dolore dei famigliari della vittima e all’ira degli amici e dei vicini, viene data voce all’uomo della strada che non vede altra via d’uscita che quella di ucciderli tutti. Si ribellano i Procuratori della Repubblica: la vera soluzione è di dare maggiore potere ai magistrati ed abbassare il livello delle garanzie che, troppe, legano le mani ai poveri inquirenti che impotenti vorrebbero ma… non possono. Di fronte ad un allarme tanto diffuso, io pure temo e, con i miei pochi mezzi, cerco di documentarmi. I numeri, però, mi confondono perché rimandano una visione affatto diversa da quella accreditata da media, politici e Magistrati. Nel 2002 in Italia, gli omicidi sono diminuiti. La sola New York, dove il nuovo sindaco è quel padrino della tolleranza zero, conta più morti ammazzati dell’intero stivale. Sono in aumento i cosiddetti piccoli reati. Il 70% dei crimini, in quelle che si considerano le capitali del delitto, Roma, Milano, Napoli, sono commessi da tossicodipendenti; il rimanente 30% è a carico degli immigrati. Ma allora, di fronte a questi dati che ci affermano che i crimini più gravi sono in diminuzione e globalmente il nostro paese è più sicuro di quanto non lo fosse gli scorsi anni, e in ogni caso infinitamente meno degrado della capitale economica U.S.A., dove pure regna la violenza di Stato che qui tutti invocano: perché tanto allarme? La risposta deriva dall’analisi dei dati. Se gli omicidi sono diminuiti, desumo che la lotta alla malavita organizzata stia dando i suoi frutti. Se la maggior parte dei delitti minori è commessa da tossicodipendenti ed extracomunitari l’allarme non è "criminale" ma doppiamente sociale: in primo luogo perché non si è riusciti (non si è voluto) a dare una risposta al dramma della droga non pensando neanche ad incidere sulle cause che conducono decine e decine di migliaia di giovani a rifugiarsi negli stupefacenti (frustrazioni, smarrimento delle motivazioni, sentimento d’impotenza ecc.) troppo spessi indotti da modelli sociali inarrivabili e dalle scarsissime opportunità offerte, mettendo poi in piedi veri e propri "carrozzoni" per il recupero dei tossicodipendenti che altra funzione non hanno se non quella di succhiare soldi alle casse dello Stato, senza produrre altro frutto che non sia la totale demotivazione degli operatori seri costretti a lottare contro i mulini a vento. Ai Ser.T. si forniscono mezzi economici limitatissimi, personale insufficiente ed inadeguato che, non appena possono (ed anche quando non potrebbero), si rifiutano di riconoscere come "tossici" anche coloro che prima di essere arrestati erano in cura, sia per realizzare un risparmio economico che per evitare di sovraccaricare di lavoro lo scarso personale, favorendo strutture private, laiche e confessionali, che spesso alimentano forti dubbi sulla scientificità dei loro sistemi. La soluzione auspicata al problema che portano con sé gli extracomunitari è raccoglierli nei campi di concentramento per poi rispedirli a casa. Ecco dunque il secondo vero motivo d’allarme sociale: la gente, in Italia, ha smarrito i valori di solidarietà umana. La solidarietà con le vittime è giusta e sgorga dal cuore: ma quella con i giovani che coltivano gravi problemi d’esistenza e bruciano in breve spazio le loro vite e quella con gli uomini che cercano di sfuggire alla fame e agli eccidi per tentare di darsi un futuro migliore, se non meramente di sopravvivere, e altrettanto giusta e necessaria. Il controllo del territorio è doveroso, misura imprescindibile. Va però accompagnato da decisi interventi indirizzati alla rimozione delle cause che portano le persone all’uso di stupefacenti e a commettere reati per pagarne il costo. Nessun intervento "muscolare" può dar frutti perché sia l’uso della forza che quello del carcere lasciano, infatti, i problemi preesistenti e anzi li amplificano. Uguale il discorso vale per gli immigrati da paesi più poveri: rimandarli a morire di fame dalle loro parti significa vederli tornare e lottare per la sopravivenza. Nel guazzabuglio di proposte che arrivano da ogni parte non n’esiste una, dico una, che punti alla soluzione delle cause scatenanti. Nessuna tiene conto che anche i rei sono uomini, che hanno sbagliato ma uomini. Quando si sente la gente comune auspicare per il ladro anche la pena di morte e si ascoltano i toni forti dei "giardinieri" della politica (vedere il film "Oltre il giardino" profetico per quanto riguarda il nostro Paese), ci si rende conto che il principale problema non è la criminalità, sempre esistita e inestirpabile, bensì il consenso civile che più non tollera lo sbaglio e il diverso, mentre adeguati interventi potrebbero ridimensionare il problema criminale, quello sociale e di difficilissima soluzione: per inculcare nella gente il senso dei valori smarriti o non più riconosciuti, storicamente, richiedono secoli. Credo che il concetto "prevenire è meglio che curare" sia ormai identificabile solamente come spot pubblicitario per qualche marca di dentifricio: unica prevenzione effettuata mandando la gente in carcere. E’ scontato che la funzione del carcere sia punitiva e, peraltro un tantino "vigliachetta", perché la punizione inflitta colpisce soprattutto i legami affettivi e i sentimenti rendendo ancora più arduo il reinserimento; sì, perché, quanto meno qui a Bologna, a parte il sovraffollamento e la carenza di addetti al fantomatico reinserimento, non sì "vive" poi così male. Però la funzione della detenzione dovrebbe essere anche quella di fare capire al reo che esiste un modo diverso di vivere e creare le condizioni in modo che egli non arrechi più danno al resto della società; accade quindi, se non altro per spirito di sopravivenza, che l’intenzione abbastanza comune sia, anche se in molti casi utopistici, quella di uscire e condurre una vita serena, dopo avere pagato il proprio debito con la società, e quindi diviene di vitale importanza mettersi ed essere messi alla prova: l’uscire in permesso premio prima e, successivamente, in affidamento o in semilibertà diventa in questo senso fondamentale. Chiaramente tutto ciò deve accadere nei tempi stabiliti dalla legge perché non è semplice far capire come la giustizia, ponendo delle regole con il codice penale e la procedura sia tassativa, irreprensibili e soprattutto attentissima alle tempificazioni quando deve punire (quindi in pratica togliere anni della tua libertà), ed invece sia approssimativa e farfallona quando deve concedere, seguendo le regole poste dall’Ordinamento Penitenziario, ridandoti una possibilità, da libero, di rifarti una vita. Se voi promettete a vostro figlio una vacanza, ho quant’altro gli potrà piacere, perché a scuola è stato promosso, ne sarà entusiasta, non dormirà di notte aspettando di partire, sognerà cosa farà e, nell’immaginario, sarà la vacanza più bella della sua vita perché l’ha guadagnata con il suo impegno. Se però la promessa non verrà mantenuta o sarà, di volta in volta, rimandata la data della partenza, quando preparerà i bagagli sarà esausto e l’interesse per la vacanza scaduto, oltre a ritenervi un bugiardo e poco affidabile; se poi a ciò aggiungete la vostra rigidità, con effetto immediato, nel punirlo, per qualche marachella che ha combinato, penserà che siete ingiusti e che impegnarsi per comportarsi bene non serve a nulla. Beh, in carcere si è un po’ tutti bambini!!! La legge Gozzini è, a tutti gli effetti, una legge che determina delle regole e delle tempificazioni, quindi, se le regole sono rispettate dai detenuti e i tempi invece no, vuole dire che la giustizia è morta. Si ha l’impressione che il secessionismo tanto invocato dall’On. Bossi abbia, nella giustizia, già l’applicazione perché in alcune regioni d’Italia, in ottemperanza con l’O.P., si procede come dettato dai legislatori, mentre in altre no. Intanto godiamoci questo i nuovo medioevo, fatto d’inquisitori, forcaioli, politici inetti e interessati, assassini e poveri disgraziati, in cui l’unico valore unanimemente riconosciuto è il denaro, accumulato non importa come: se l’hai fatta franca puoi anche governare l’Italia…!!!
|